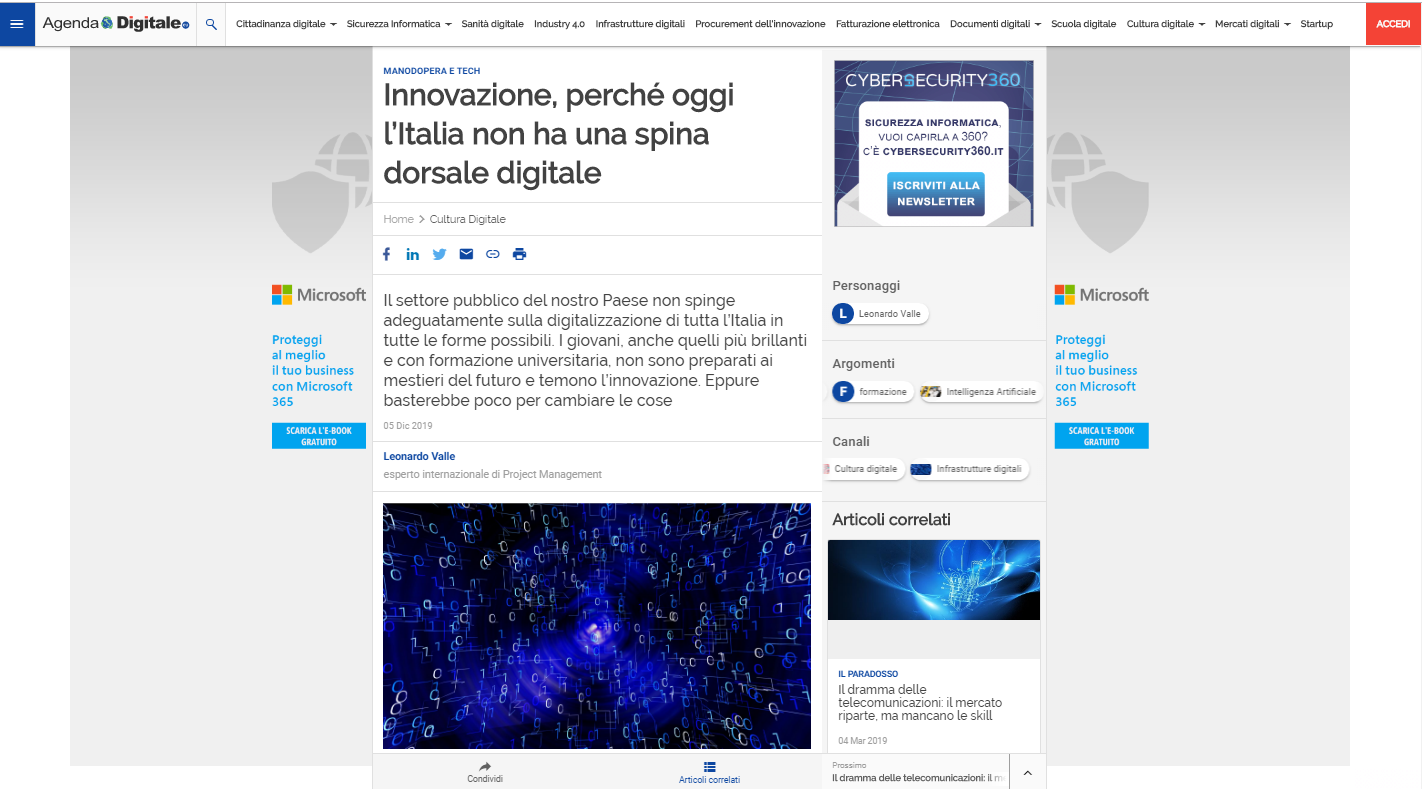La biglia di Pantani
Storia di due cadute in discesa e una vittoria in salita
Viva Pantani che a fare duecento chilometri con cinque
salite ci mette meno che un automobilista a fare la Bologna-
Rimini con sette ingorghi. Viva Pantani che fa vestire di rosa
confetto e giallo squillante le ladies in nero e i rudi bagnini.
Viva Pantani che ci regala una sana ventata di politeismo pagano
nel monoteismo annichilente del dio Calcio. Viva il Piccolo
Uomo Dalle Grandi Orecchie che, anche se foderato di scritte
di sponsor, ci fa ancora illudere che nello sport, a differenza
che nella politica, quando uno vince non diventa subito un
manovriere del compromesso, ma va ancora all’attacco.
STEFANO BENNI
La bicicletta non è un viluppo di metallo, un insieme inerte
di leve e ruote. È arpa birmana. Sinfonia. Un dono della vita.
Trasforma in musica storie di uomini. Anche tragedie.
CLAUDIO GREGORI
Nota per il lettore.
Nel 1974 Radio Rai lanci. un programma dal titolo “Le interviste impossibili”. Si trattava di un format totalmente nuovo in cui importanti esponenti della cultura contemporanea (uno su tutti Umberto Eco) intervistavano dei personaggi impossibili (da cui il titolo) perché appartenenti a un’altra epoca storica o di fantasia. Il programma riscosse un grande successo e diede vita a innumerevoli spin-off tanto da diventare col tempo una sorta di esercizio di stile.
Questa storia inizia da lontano e probabilmente non è la storia che ci si aspetterebbe di leggere su Marco Pantani, in un libro di questo tipo. Questa storia non parla di pirati e maglie rosa o gialle. Questa è la storia di un campione ancora senza titoli, ma con qualche vittoria, ed è la storia di un uomo che non conosce paura. Diretto, schietto e franco, come diretti schietti e franchi possono essere un bicchiere di vino e una piadina crudo, rucola e squacquerone. Questa è la storia di un ciclista che ancora non è diventato leggenda e che è in perenne bilico tra il farcela e il mollare. Tra il tagliare il traguardo alzando le mani e indossando la maglia e vivere una vita all’ombra di quel quarto d’ora di celebrità che si è conquistato pedalando tra le strade italiane e francesi, mettendo in evidenza una pettinatura sempre più diradata e due orecchie a sventola.
Chissà quante volte, in quegli anni così faticosi e inconcludenti, Pantani avrà pensato di staccare i piedi dai pedali, sganciare la ruota, infilare la bici dentro la macchina e tornarsene a Cesenatico. La sua città. Inventarsi una vita lì, a dare una mano a mamma Tonina e papà Ferdinando nel chiosco di piadine e a fare l’aperitivo sul lungo canale, nel porto progettato da Leonardo senza pensare a niente. Parlando di Milan, di macchine e belle donne. Nessuno gli avrebbe detto qualcosa se si fosse arreso. Beh, con tutta la sfiga che ha avuto, si sarebbero limitati a dire. Questa storia inizia con una vecchia canzone che faceva pressappoco così:
Milano/Sanremo a rotta di collo
Liegi/Bastogne andata e ritorno
Stare davanti senza mai mollare
Nessuno oramai mi riesce a cambiare
Son nato nel mare ma scalo montagne
Cerco illusioni invece trovo emozioni
Ho il fiato del tempo sempre sul collo
Nessuno ti giuro mi cambier., tappe intermedie mai
E ti porterò con me lassù, la bici, io e tu, in maglia rosa sempre più
E adesso pedala, sulla mia sella da cowboy per inseguire il cielo
e poi
Pedala pedala, perduto nella dolce scia a tutta birra e così sia
Apro gli occhi e sono su
Il gruppo è lontano non lo vedo già più
Pedalo pedalo e arrivo alla cima
Al Tour e alla Vuelta penserò domattina
La rabbia mi spinge e mi porta distante
In salita e in discesa mi mangio i tornanti
Dietro e davanti mi applaudono in tanti
Vorrei restar sempre cos. in maglia rosa e poi
Il vento e le moto sorpassano, la fatica tocca solo a me ma ho
voluto la bici e adesso
E adesso pedala, sulla mia sella da cowboy per inseguire il cielo
e poi
Pedala pedala, perduto nella dolce scia a tutta birra e così sia
E adesso pedala, la tappa è dura, piove, ma il cuore certo
basterà
Pedala pedala, la bici l’ho voluta io e tiro la volata ormai
E adesso pedala, sulla mia sella da cowboy per inseguire il cielo
e poi
Pedala pedala, perduto nella dolce scia a tutta birra e cos. sia
E adesso pedala…
Pedala pedala…
Adesso Pedala, sigla del Giro d’Italia 1996…se la ricorda Pantani? «Cavolo, e come potrei scordarmela? La cantavo io!»
Una delle poche edizioni del giro trasmesse da Mediaset che per un breve periodo ha visto alternarsi alla voce di De Zan padre quella di De Zan figlio… Questo rap melodico di cui si sarebbe volentieri fatto a meno (senza offesa, eh!) è in realtà carico di significato per chi è stato appassionato di ciclismo negli anni Novanta. Erano del resto gli anni in cui nasceva la leggenda del Pirata…
«Io però mi sono divertito a cantarla, lo sa?» (Ride ndr).
Beh, lo immagino. Diciamo però che non ci ricordiamo di lei per la sua voce…«Meno male!»
Prima di farle qualche domanda vorrei chiederle un’altra cosa.
«Lei è l’intervistatore, questo è il suo libro… mi pare il minimo…»
Possiamo darci del tu?
«Sarebbe il caso, Federico!»
Grazie Marco. Adesso pedala fu registrata durante la tua riabilitazione dal terribile incidente alla Milano-Torino che mise a repentaglio la tua carriera.
«Sì, quando l’ho registrata avevo da poco abbandonato le stampelle. Mediaset mi offrì questa opportunità… era un modo per essere comunque al Giro, un modo per non far dimenticare agli italiani la mia faccia, se vogliamo».
È il 18 ottobre del 1995, siamo sulla discesa di Pino Torinese quando tra te e la tua vita ci si mette una jeep. Contromano e in un percorso che doveva essere messo in sicurezza. «Paradossalmente ricordo poco e tanto al tempo stesso di quei momenti. Ricordo per esempio di essere letteralmente volato in aria. Ancora con i piedi attaccati alla bici. E poi mi ricordo l’asfalto. L’asfalto è duro lo sai? Chi guarda il ciclismo in televisione senza essere mai andato in bici non si rende conto di quanto faccia male cadere sull’asfalto».
Anche da fermi… «Bravo, anche da fermi… vedo che ne sai qualcosa».
[Muovo con complicità il braccio sinistro che ancora scricchiola dopo una caduta e sorrido guardando il pirata. Che si trattava di una caduta da dilettante, in salita, decido di ometterlo]. E poi? «E poi mi ricordo di essere per terra e di avere la gamba rotta. Mi ricordo il dolore, mi ricordo che cercavo di non guardare la gamba, cercavo altri punti su cui indirizzare lo sguardo. E aspettavo l’ambulanza».
Tibia e perone e rischio di chiudere la carriera lì, a Pino Torinese. E pensare che quel 1995 stava terminando tutto sommato bene. «Vero. Arrivavo da una bella prova al Tour, il Giro lo avevo saltato sempre per colpa di un contatto ravvicinato con una macchina. Potevo solo migliorare, sentivo crescere le aspettative intorno a me, e invece…»
E invece come ci si rialza per l’ennesima volta?
«Quella volta fu dura. Davvero. Non sono un uomo di scienza e non so se ho rischiato per davvero di smettere. Però l’ho pensato. E se al nostro livello arrivi a pensare qualcosa del genere, significa che allora una parte di te – anche se non te ne accorgi – sta già abbandonando la nave. Un po’ del tuo carattere e della tua forza si stanno ammutinando e tu non puoi farci niente, perché sei bloccato dentro il letto».
Che ricordi hai dell’immediato post incidente?
«Ricordo che dopo qualche giorno, forse una settimana o poco più che ero in ospedale a Torino, venne a trovarmi un amico, un vicino di casa prima ancora che un grande compagno di squadra, Marcello Siboni. Gli dissi senza avere il coraggio di guardarlo negli occhi: “Sibo, stavolta non lo so se ce la farò a rimettermi in piedi”».
Fine ottobre, lasci l’ospedale e anche Torino. Sei sopravvissuto allo schianto, inizia forse la parte più difficile…«Devo rimettermi in piedi e devo assolutamente tornare a essere competitivo».
E non solo…«Vero, devo rimettermi in piedi, devo tornare a essere competitivo e voglio tornare a vincere».
Ci ripensi mai a quei giorni?
«Ogni tanto di quel periodo mi tornano in mente due cose. La prima è il momento in cui sono tornato in bici. Era il 23 marzo del 1996. Esattamente 157 giorni dopo l’incidente. 157 giorni dopo essere decollato con la mia bici grazie a un frontale con un’automobile contromano. Feci un giro per Cesenatico».
Cosa provasti in quel momento?
«Mi resi conto che avevo scordato quanto fosse bello andare in bici».
E la seconda cosa?
«L’amore. Avevo ancora le stampelle quando l’ho incontrata. Christina. Lavorava in una discoteca».
E intanto il 1996 sfila via. Il Giro lo vince Tonkov, il Tour lo vince Riis. Il 1997 inizia con l’addio alle competizioni di Miguel Indurain e ti riserva qualche novità.
«Una di sicuro… ma l’altra?»
Intanto dimmi quella che ti ricordi tu.
«Beh, ho cambiato squadra ed è stato un momento fondamentale per la mia carriera. Ancora non lo sapevo, ma con la Mercatone Uno e i miei compagni di squadra avremmo scritto pagine importanti per questo sport».
Ti sentivi che stava per succedere qualcosa?
«A malapena ricominciavo a pedalare… ma se ti dicessi di no, che non me lo sentivo, ti direi una bugia. E anche grossa».
E la seconda novità di quell’anno?
«Giuro non me la ricordo…»
Sembra che nacque in quelle giornate il soprannome Pirata. Avevi la testa piccola e tutti i cappellini ti stavano larghi…così tua madre ti suggerì di indossare un fazzoletto per proteggerti dal sole…
«È vero! Nascevano insieme questo soprannome e la voglia di fare un buon Giro».
E invece… a proposito di Giro…«Niente. Caduto. Addio».
Di solito si dà la colpa ai gatti neri ma stavolta…
«Pare che fosse bianco. Io mi ricordo solo che ho visto Enrico Zaina cadere. E poi ero per terra anche io. Ho provato a rialzarmi di scatto e mi sono reso subito conto che provavo troppo dolore. Non era una semplice caduta, non c’era nulla di rotto, ma il mio corpo non stava rispondendo. E poi ho sentito le lacrime che mi scendevano sul viso. Stavo piangendo. Si avvicina Siboni a soccorrermi, ma niente, credo capisca subito pure lui che c’era poco da fare. Risalgo in sella, finisco la tappa… ma so già che mi ritirerò».
E si ricomincia. Come un perverso gioco dell’oca… riparti dal via.
«Sì. Ero lacerato e non soltanto nei muscoli. Avevo lavorato sodo per fare bene il giro del ’97… avrei voluto perdere perché sconfitto dagli avversari e non per l’ennesima volta dalla sfortuna».
Un 1997 che vedeva tornare un italiano in cima al Giro…
«E quell’italiano non ero io… ma avevo altro a cui pensare a quel punto. Quando vinse Gotti ero già proiettato verso altri obiettivi».
A tal proposito come hai gestito questa ennesima caduta?
«Con pazienza. Si aspetta che guariscano le ferite, si risale in bici e si lavora sodo per il Tour».
Già, il Tour del 1997. Nella prima settimana quante volte sei caduto?
«Lasciamo stare… ma…»
C’è un ma…?
«Sì… ero nel bel mezzo del gruppo quando ci fu una delle cadute più grosse della storia del Tour de France. Caddero a terra qualcosa come quaranta atleti e io no. Per un soffio evitai quel groviglio di biciclette…»
Un segnale positivo?
«Non potevo non interpretarlo diversamente».
Anche se la seconda settimana arrivò la bronchite.
«Un lazzaretto! Però sentivo che ancora potevo lasciare un segno in quelle tre settimane. La gamba c’era… mancava un po’ il passo, ma stavo crescendo».
Ti ricordi che hai fatto il 19 luglio di quell’anno?
«C’era l’Alpe d’Huez. La mia ultima vittoria era stata proprio lì, due anni prima».
Corsi e ricorsi storici…
«In mezzo due anni di cadute, letti di ospedali, gatti, jeep, medici, fisioterapisti. Quel giorno mi sento bene. Con la squadra decidiamo che si arriva tutti insieme ai piedi della salita e poi si inizia a fare selezione. E le cose vanno effettivamente così, solo che io scalpito e faccio saltare tutte le strategie. Mi sento bene, mi sento leggero. Mi tolgo gli occhiali e li passo a Siboni. «Me li tieni?» gli dico. Lui capisce. Quel gesto per me è come un interruttore da accendere. Significa alleggerirmi per partire».
E infatti parti subito.
«Inizio con una progressione e li metto tutti in fila. Restano Virenque che ha la maglia a pois e Ullrich che è in maglia gialla. Si stacca Virenque e rimane Ullrich, ma per poco. Guardo davanti a me e noto qualcosa di strano negli occhi dei tifosi a bordo strada. Non guardano me, guardano dietro. In quel momento capisco che anche la maglia gialla sta faticando. Capisco lì che quel giorno vincerò. Capisco lì che sono tornato».
Da un punto di vista tecnico affrontasti quella salita rilanciando in continuazione anche quando non serviva più perché avevi già messo tutti dietro di te. E poi tenevi le mani molto basse, sulle corna del manubrio. Fatico solo a guardarle quelle immagini…
«Sì, ma non lo faccio per un motivo particolare, mi viene naturale. In quel modo mi sembra di comandare di più la bici. Mi sento un domatore quando ho le mani così basse sul manubrio».
A quel punto siete tu e la salita. Non resta che arrivare in cima…
«So di essere solo fino al traguardo, lungo la strada mi passano acqua, me la getto in testa, fatico e spero che duri il meno possibile. Ho anche la forza per allontanare con un sinistro un tifoso un po’ troppo molesto. Sento che la sfortuna è lontana. Che ha smesso di pedalarmi al fianco. Quel giorno la sfiga è rimasta ai piedi dell’Alpe d’Huez.»
E poi il traguardo. Non alzi i pugni, ma prendi a pugni qualcosa.
I pensieri, i fantasmi, le paure? E poi l’urlo… Se ci ripenso ho i brividi, lo sai? Mi ricordo dov’ero quel giorno, ho davanti agli occhi l’immagine tua nitida, con la maglia blu della Marcatone che urli.
«Lì per la prima volta ho capito cosa fosse un urlo di liberazione. In quel momento stava finendo un incubo».
E noi lo capimmo con te Marco. Grazie.
«Grazie a te».
Pantani si alza, sorride, mi stringe la mano e se ne va. «Mi aspettano», dice. Vorrei abbracciarlo forte e dirgli grazie per tutto quello che mi ha fatto vivere, per tutto quello che ha rappresentato per me. Per come e quanto mi ha aiutato senza nemmeno saperlo. Provo a seguirlo, giro l’angolo ma è già lontano. Sta pedalando sulla sua Bianchi, celeste. Ha le maniche della camicia arrotolate. Muove la testa da destra a sinistra. Forse canta. Forse fischietta. Penso che dio – se c’è – non gioca a dadi, come sosteneva Einstein. Dio piuttosto gioca a biglie sulla spiaggia di Cesenatico e quella con la faccia di Pantani ha deciso di tenerla solo per lui.
Era il 1997.
Il mito del Pirata stava nascendo.
Tutto doveva ancora cominciare.
Tutto doveva ancora finire.